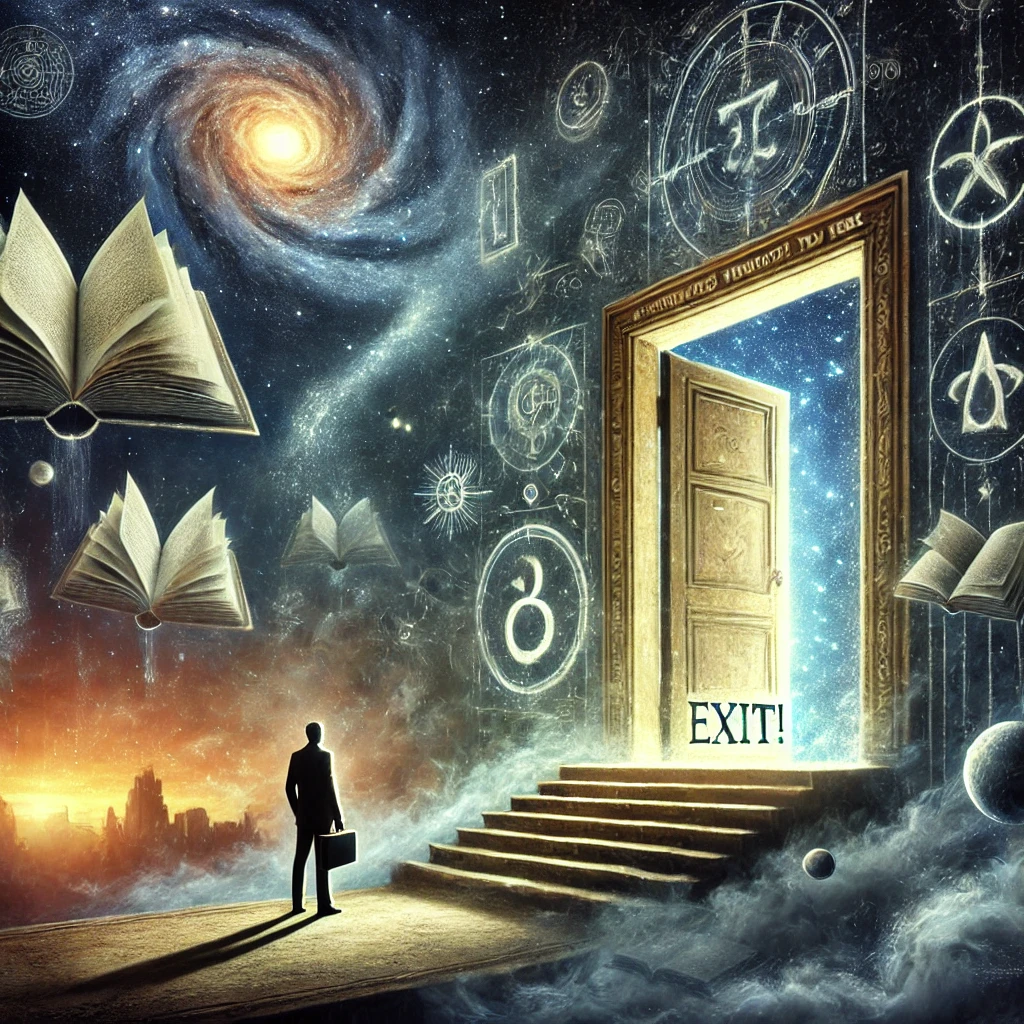
Nel buio totale, con scritte illuminate da una fievole fiammella di una candela, un monito ben preciso mi colpì: SE LA CURIOSITÀ TI HA CONDOTTO FIN QUI: ESCI.
Cari FF.rr non vi nascondo il mio sgomento nel momento in cui lessi quella frase, ancora oggi, quando c’è da allestire il gabinetto di riflessione, lo guardo con molto sospetto e rispetto.
Fino a quel momento avevo considerato la curiosità come la benzina da mettere nel motore della conoscenza, ed ora mi veniva “consigliato” di lascarla da parte. Forse la rinascita iniziava proprio da lì, dal far cadere tutto ciò che fino a quel momento consideravo come inamovibile certezza assoluta.
Nella vita profana non avevo mai pensato alla curiosità come un comportamento con accezione negativa, e pure in uno dei momenti più toccanti che si possano vivere, l’iniziazione, mi veniva posta in modo perentorio questa chiave di lettura.
Si dice curiosità e viene in mente l’occhio. “Concupiscientia oculorum”, concupiscenza degli occhi, la chiamava Agostino d’Ippona, e metteva in guardia dalla tentazione di voler contare le stelle o i granelli di sabbia in quanto, secondo il suo parere, quella curiosità non solo era vana ma costituiva un ostacolo sul cammino della devozione.
Anche Bernardo di Chiaravalle nel dodicesimo secolo colloca la curiosità tra l’accidia e l’orgoglio: “Ci sono coloro che vogliono sapere al solo fine di sapere, e questa è turpe curiosità”.
La curiosità percettiva è generata da cose molto diverse dal solito, da stimoli nuovi, ambigui o enigmatici, essa ci spinge in particolare all’esplorazione attraverso i sensi e tende a diminuire in seguito a un’esposizione continua allo stimolo. Non può e non deve essere questa la curiosità che anima la nostra ricerca. Sul lato opposto, secondo una linea di continuità, c’è la curiosità epistemica, che consiste nel vero e proprio desiderio di conoscenza ed è alla base delle ricerche scientifiche e filosofiche, nonché delle ricerche spirituali.
Si dice curiosità e si pensa al mondo esterno da esplorare, da conoscere, da indagare. Eppure il mondo interno di ognuno di noi non è più noto di quello esterno, anzi. Ci conosciamo poco e siamo per molti aspetti un mistero a noi stessi. Anche quando non si sa quasi nulla di Freud si cita il suo: “nessuno è padrone in casa propria”.
Allora dobbiamo investigarci in continuazione e, seppur scoprendo aspetti di noi che non erano mai emersi prima, siamo attratti e spesso sorpresi dalle zone in ombra e dai territori ignoti del nostro mondo interno.
La curiosità non deve esser rivolta all’esterno, non dobbiamo cercare qualcosa fuori da noi, piuttosto tutto ciò deve riguardarci intimamente. Così possiamo intendere facilmente che non si può parlare di curiosità in modo generico, ma che di questa ne esistono diverse tipologie.
Un percorso iniziatico non può essere intrapreso e portato avanti per “semplice” curiosità, l’input non può originare da un qualcosa di così istintivo, anzi l’impulsività di tale comportamento va combattuta e contrastata.

Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.